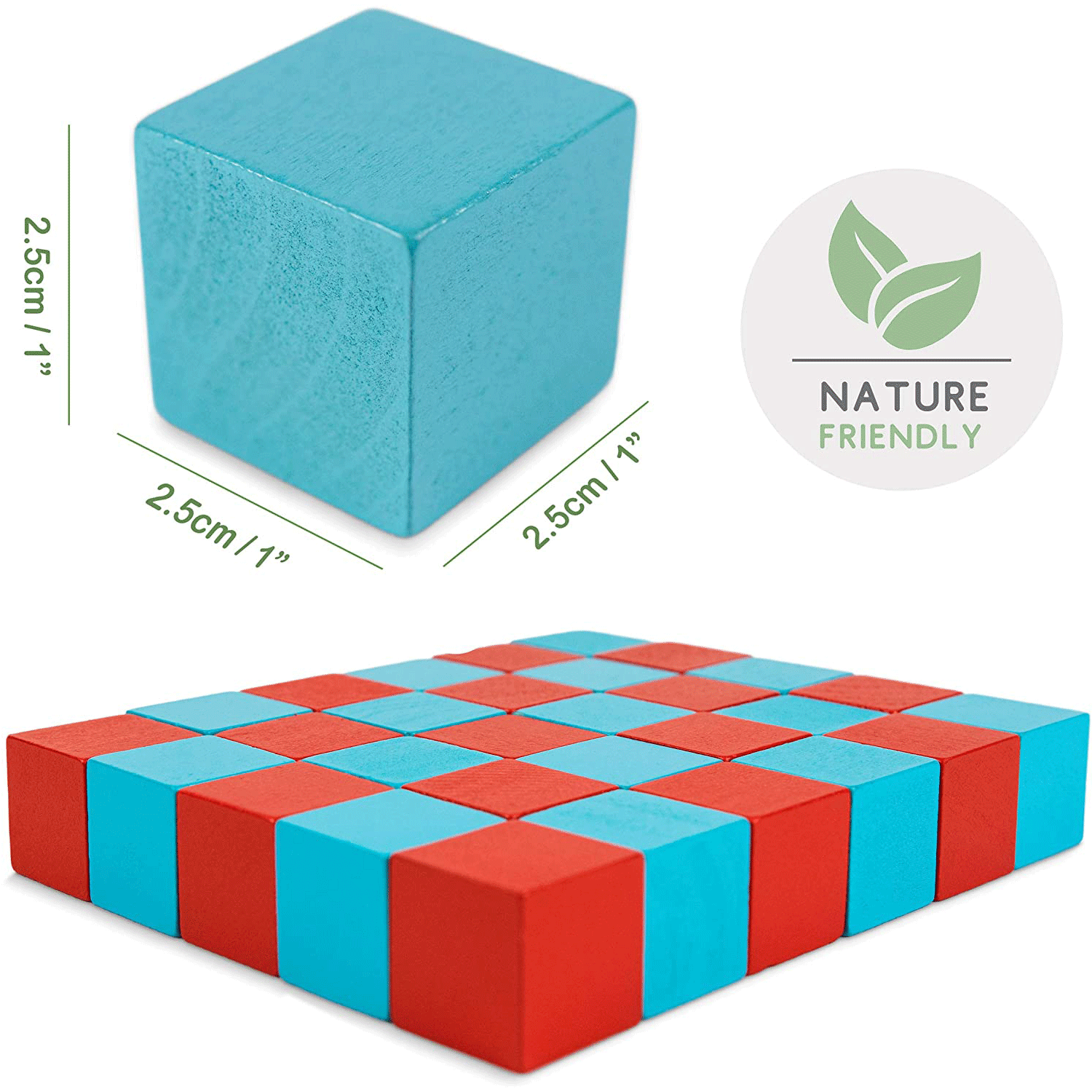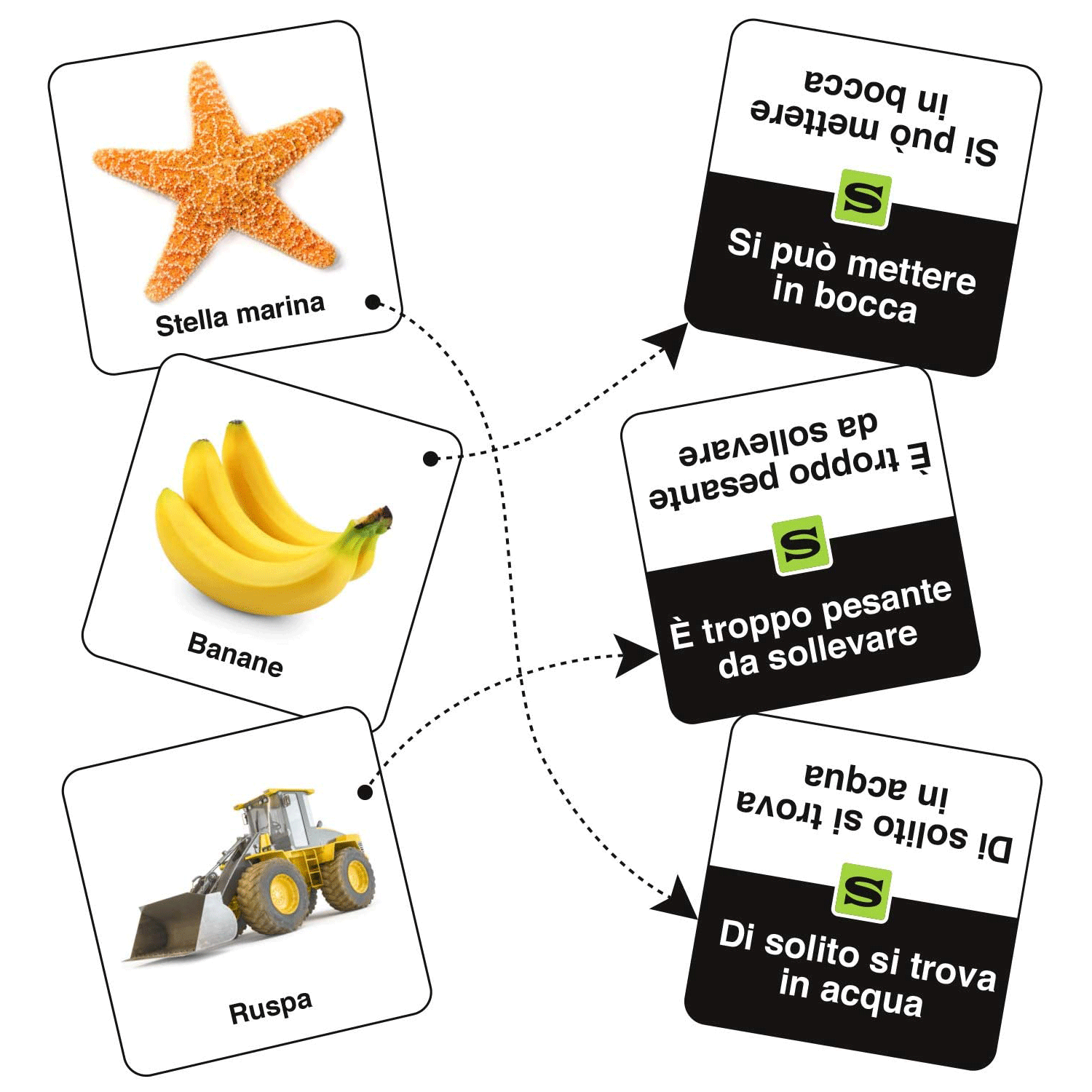AGGRESSIVITÀ - Introduzione Teorica
Definizioni a confronto
Il concetto di aggressività è stato da sempre oggetto di studio nei più svariati campi della ricerca. A livello semantico il termine include un ampio insieme di idee e una vasta gamma di fenomeni che a loro volta riflettono gli orientamenti, talvolta contrastanti dei vari ricercatori. Definirla come mero comportamento caratterizzato da azioni verbali, non verbali o fisiche che causano un danno a un’altra persona, all’ambiente o a sé (Morrison,1990), è quindi riduttivo poiché non considera i fattori causali, emozionali e intenzionali che rendono tanto peculiari ognuna di queste condotte. L’aggressività si rispecchia piuttosto nella definizione coniata da Storr (1968)1 di “parola valigia” in quanto amalgama significati molto diversi tra loro: un’emozione aggressiva giustificata o ingiustificata, un atteggiamento mentale, un istinto, un’azione e così via. La difficoltà, infatti, sta soprattutto nel dover distinguere forme di aggressività comunemente giudicate deplorevole, da quelle invece necessarie alla sopravvivenza o alla maturazione psichica del soggetto.
“Quando il fanciullo si ribella all’autorità, diciamo che è aggressivo, tuttavia in quel modo egli manifesta un impulso di indipendenza necessario e prezioso al pro cesso di crescita” (Winnicott)2.
La tipica aggressività e oppositività del bambino di due anni, è infatti un indice positivo che riflette il progredire fisiologico del processo di separazione – individuazione che lo porterà dal sentirsi in simbiosi fisica, emotiva e mentale con il caregiver, ad affermarsi e riconoscersi come artefice e protagonista del proprio corpo e del proprio pensiero.
L’eterogeneità dei significati del termine e i contenuti che esso restituisce sui piani relazionale, individuale e sociale, meritano dunque un necessario approfondimento, e un’analisi dettagliata dell’atteggiamento o dell’azione aggressiva.
Aggressività o aggressione?
Distinguere il concetto di “aggressività” da quello di “aggressione”, non è sempre facile, ma, tanto più in terapia neuropsicomotoria, è di fondamentale importanza.
Il primo, è infatti definito da De Ajuriaguerra3 come una componente affettiva dell’uomo, che non sempre si manifesta con atti di aggressione.
Accettare la definizione di aggressività come azioni intenzionali che mirano a recar danno, presuppone un necessario rapporto diretto fra intenzionalità e scopo, ossia che l’azione aggressiva sia pienamente volontaria, pensata e programmata con lo scopo di ledere. Questa concezione non tiene però conto della profonda differenza tra scopo e intenzione, e in particolare del fatto che non sempre l’effetto si può identificare nello scopo. E’ molto raro che lo scopo dell’azione di un bambino sia quello di recar danno all’altro: molto spesso esso è piuttosto difendersi, affermarsi, appropriarsi, stabilire o modificare l’ordine gerarchico (Berti et al., 2005).
Diversamente, il termine aggressione si riferisce al comportamento manifesto, all’“attacco non provocato”, agonistico, fisico o verbale, difensivo o offensivo.
Aggressività come relazione
Non sempre dunque, l’aggressività rimanda a significati negativi o distruttivi; non sempre l’aggressività si esprime con “atti di aggressione” oggettivamente osservabili. Riprendendo l’etimologia della parola (ad-gradior, andare verso, avvicinarsi), si comprende come è insito un significato di avvicinamento, di relazione, che può essere manifestato in diversi modi.
“L’aggressività può avere un valore di dialogo e in c erte occasioni essere costruttiva” (De Ajuriaguerra).
La difficoltà di definire in modo chiaro e univoco il concetto di aggressività deriva anche dal dover fare i conti con l’interpretazione del comportamento in questione. Interpretare (inter-pretium, accordarsi) significa interagire con il mondo non solo secondo il principio di causa -effetto, ma anche e soprattutto secondo processi di comunicazione. In particolare quando definiamo aggressivo il comportamento dell’altro, si intrecciano almeno tre ambiti interpretativi: quello di tale persona, quello dell’osservatore, e quello della persona verso cui l’aggressività di manifesta, nel caso in cui l’azione aggressiva è rivolta verso l’altro. Identificandolo come aggressivo, l’osservatore etichetta alcuni tratti del comportamento, sulla base di influenze culturali e di regole private; la risposta che poi invierà al soggetto, porterà lo stesso a percepirsi e identificarsi in tale etichetta, in quanto ognuno di noi si vede e si costruisce anche attraverso lo sguardo dell’altro.
La posizione epistemologica dell’osservatore può dunque plasmare la concezione di aggressività a seconda che vengano tenute in considerazione la descrizione fisica del soggetto (posture, espressione del viso, voce etc..), la distruzione o il deterioramento dell’oggetto (o persona) preso di mira, l’intenzionalità dell’atto, oppure il vissuto fantasmatico che si cela dietro alla condotta.
E’ chiaro come il modello teorico di riferimento porti quindi a leggere un determinato comportamento in modo diverso, cogliendone alcune sfaccettature piuttosto che altre, attribuendone un significato anziché un altro.
Alla luce delle ricerche più attuali, la classificazione e soprattutto la comprensione dell’atto aggressivo è tanto più precisa quanto si considerano almeno tre fattori: le caratteristiche dell’azione, l’intenzionalità, e lo stato emotivo del soggetto. Affrontare un’analisi che pone le basi sul piano oggettivo e osservabile, che prima ancora della motivazione intrinseca, vada ad indagare l’azione tangibile, permette di poter in qualche modo identificare l’atto aggressivo in base ad alcuni criteri di inclusione: la condotta aggressiva può manifestarsi in forma diretta (distruttiva), cioè indirizzata verso l’interlocutore scelto attraverso l’attacco fisico o verbale, oppure indiretta (non distruttiva), quando cioè il sentimento aggressivo viene scaricato attraverso altre modalità, quali ad esempio un repertorio motorio eccessivamente ricco e disorganizzato, o, molto frequente nel bambino, un gioco caotico e disorganizzato.
Aggressività auto ed etero-diretta
Tra gli atti aggressivi diretti si distingue l’atto rivolto a sé (auto-diretto), da quello diretto all’esterno (etero-diretto).
Si parla di aggressività auto-diretta quando il soggetto mette in atto condotte automutilatorie dirette verso il proprio corpo e che provocano un danno fisico ai tessuti (Tate e Baroff, 1966). Le modalità messe in atto sono più comunemente colpirsi, mordersi, graffiarsi, sbattere la testa o pizzicarsi, tutti comportamenti che si manifestano con una certa frequenza nei quadri di gravi encefalopatie associate a ritardo mentale severo o profondo, nei disturbi pervasivi dello sviluppo senza linguaggio verbale, nei disturbi psicotici e di personalità, o in stati di abbandono o gravi carenze affettive.
Tali condotte possono portare con sé significati molto diversi: dall’assenza di percezione del dolore, a una grave disorganizzazione dei confini corporei, fino a un grave disturbo dell’integrazione sensoriale per cui il soggetto è alla continua ricerca di un’autostimolazione. Duchè (citato in Marcelli, 2013) mette in luce come dinamiche autolesive, indipendentemente dalla condizione patologica del soggetto, si possano di frequente osservare in determinate situazioni, quali:
- in risposta ad una frustrazione;
- come richiamo o sollecitazione dell’ambiente (valore comunicativo);
- come rivolgimento su di sé dopo un’interazione aggressiva proveniente dall’ambiente;
- come comportamento autostimolante in un contesto di isolamento.
Quest’ultima ipotesi, in particolare, si basa sull’assunto che un organismo abbia bisogno di un certo livello ottimale di attivazione, che se si altera, può dar luogo all’emissione di comportamenti compensatori. Ciò è particolarmente evidente tra i soggetti con grave disabilità intellettiva, che, ai fini di mantenere un ritmo o una quantità complessiva di comportamento emesso relativamente costante nel tempo, aumentano non solo i comportamenti stereotipati, ma anche quelli adattivi (Repp, Karsh, e Van Acker, 1987).
Nel considerare un’azione etero-aggressiva ci si scontra nuovamente con i fattori precedentemente citati, ovvero sulla percezione di tale azione da parte di chi la subisce.
Se le prime condotte aggressive intervengono fisiologicamente nello sviluppo del bambino tra i due e i tre anni di vita, e plasmano anzi in modo positivo la personalità e il senso d’identità del soggetto, queste possono essere un segnale d’allarme quando non maturano in termini di modalità espressive (trasformandosi ad esempio in aggressività verbale), ma perdurano in modo pervasivo nella fase di latenza o in preadolescenza, strutturandosi soprattutto come una forte intolleranza alla minima frustrazione.
Gli atti di aggressività etero-diretta possono essere rivolti a cose, animali o persone, possono presentarsi in quadri di sviluppo neuro tipico, come associato ad altre patologie quali disabilità intellettiva, disturbi pervasivi o sindromi genetiche.
Aggressività impulsiva e non impulsiva
Considerando l’intenzionalità del soggetto, si possono differenziare le forme di aggressività impulsiva da quella non impulsiva (Vitiello et al., 1990), la prima che fa riferimento ad un atto aggressivo non programmato e no n controllato, alla seconda, al contrario è attribuito il valore di atto pianificato, premeditato, strumentale, reattivo o proattivo.
Se per l’atto impulsivo la causa è da ricercare soprattutto nel funzionamento neurofisiologico dell’individuo, è l’ambiente a ricoprire un ruolo protagonista nell’esecuzione volontaria di un atto aggressivo.
Analizzando il comportamento aggressivo non impulsivo, si può infatti fare una distinzione sulla base della predominanza dell’aspetto cognitivo – intenzionale, piuttosto che su di quello affettivo-emotivo. Nel primo caso tale condotta è definita strumentale poiché finalizzata al raggiungimento di un’altra meta predefinita, diversamente sono le condotte aggressive vere e proprie dette ostili, in cui le motivazioni sono organizzate intorno ad una motivazione aggressiva e riferite a una meta aggressiva; lo stato emotivo del soggetto, facilmente correlabile allo scopo dell’azione, sarà dunque qui orientato direttamente a fare del male alla vittima, con una lucida consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni.
Definire un comportamento o un’azione, e soprattutto interpretarlo, è indubbiamente non sempre facile. Ci si scontra, infatti, con il costante rischio di possibili travisamenti, di errate considerazioni fatte in termini assoluti, quando invece ciò non è compatibile con l’aspetto narrativo che si perpetua all’interno della relazione.
È facile inoltre, ipotizzare che l’aggressività del bambino piccolo non è sostenuta da motivazioni ostili, ma è meglio connessa a situazioni frustranti, all’imitazione di modelli di cui è stato più o meno volontariamente spettatore, o al tentativo di affermare la propria identità fisica e psichica.
L’approccio neuropsicomotorio ci insegna a mantenere sempre una porta aperta al tempo e al cambiamento, a una possibilità di trasformazione, che non può che nascere all’interno della relazione terapeutica d’aiuto, basata sulla pregiudiziale fiducia, accettazione, ascolto e valorizzazione dell’altro.
Modelli psicodinamici
Le teorie psicanalitiche che trattano di aggressività e ne evidenziano l’importanza nello sviluppo, si polarizzano principalmente attorno alla dicotomia tra causa esterna (aggressività reattiva) e causa interna (aggressività innata).
Se alcuni autori come Freud o la Klein considerano l’aggressività come una realtà indiscutibile e innata nell’uomo, l’evoluzione della stessa e le sue manifestazioni subiscono in realtà, una continua influenza dei fattori ambientali che, in accordo con i principi della plasticità cerebrale, plasmano lo sviluppo della mente umana.
L’approccio freudiano all’aggressività
Il fondatore della psicanalisi, S. Freud (1856-1939), tratta dell’argomento più volte nel corso dei suoi studi, senza tuttavia, riuscire a raggiungere quella completezza ricercata. Lo stesso autore sostiene che “ L’intero argomento non è stato trattato a fondo, e ciò che ebbi a dire in proposito nei miei scritti era così prematuro e casuale da meritare scarsa considerazione”.
Possiamo distinguere, nel percorso di studi dello psicanalista, almeno tre fasi. Partendo dal contesto clinico, ritenne inizialmente di poter identificare l’aggressività come un aspetto marginale della pulsione sessuale (libido), e solo successivamente, comincia a considerare l’opportunità che possa esserci un istinto originario di crudeltà che si differenziava profondamente dalla stessa. Se già nel secondo saggio sulla teoria sessuale (1905) Freud non esclude l’esistenza di un’aggressività non riducibile a una semplice componente della libido, è in “Pulsioni e i loro destini” (1915) che la inserisce tra le pulsioni dell’io come espressione di una tendenza all’autoconservazione e al controllo della realtà.
Il pensiero dell’autore evolve ancora in “Al di là del principio di piacere” (1920), nella cui opera l’aggressività è inserita in una visione quasi nichilistica della vita e viene vista dunque come manifestazione di un’autonoma pulsione di morte (Thanatos) che tende,e porta poi, al dissolvimento della sostanza vivente.
La teoria delle relazioni oggettuali e la psicologia dell’io
La teoria freudiana sull’origine dell’aggressività, venne ripresa e rielaborata dai successivi psicanalisti, e vanno formandosi, in particolare, due principali linee di teorizzazioni, entrambe delle quali restano comunque legate all’ipotesi pulsionale.
La prima, la psicologia delle relazioni oggettuali, approfondisce lo studio delle esperienze dell’inconscio in rapporto alle primissime relazioni fantasmatiche interpersonali e con gli oggetti ai fini della strutturazione della personalità.
La principale esponente, Melanie Klein, (1882-1960) accoglie grandemente le ultime ipotesi del fondatore della psicanalisi relative all’esistenza della pulsione di morte, e collega ad essa la presenza di precoci e innati impulsi aggressivi e distruttivi (frustrazioni, gelosie, invidie) nel neonato, preannunciatori, tra l’altro, dell’anticipata comparsa dell’Io e del Super -io. Ella sottolinea come il lattante abbia bisogno di mordere, di divorare, tanto che quando gli verranno a mancare le soddisfazioni relative allo stadio orale della suzione, le cercherà proprio nello stadio orale del mordere. Allorchè il bambino si sente frustrato dal seno negato, egli attacca l’oggetto nella fantasia aggressiva con il desiderio di distruggere la madre, distruzione che egli percepisce reale e concreta, e che solo con il tempo potrà risolvere e riaggiustare.
Contrariamente a quanto constatato da Freud, la dinamica dei fattori psichici per la Klein non si identifica solo come polarità tra impulso di vita e impulso di morte, ma soprattutto come interazione continua tra i due fattori. Il circolo vizioso dominato dall’istinto aggressivo che crea angoscia e che viene continuamente rinforzato da essa, può essere interrotto dalla forza della libido che permette lo sviluppo della consapevolezza della propria capacità di riparare e rimediare al danno procurato ai propri oggetti d’amore, esterni e interni.
Nel filone della psicologia dell’Io, che pone al centro della ricerca il legame tra le vicende pulsionali e l’adattamento, si ricorda in particolare Anna Freud (1895-1982), la quale sviluppò l’intuizione del padre circa i meccanismi di difesa.
Anna Freud, pur partendo dalle posizioni paterne, amplia e allarga il tema dell’aggressività riferendosi, in particolare, al meccanismo di difesa dell’”identificazione con l’aggressore”. Secondo l’autrice, esso permette al soggetto di mettere a riparo, difendere appunto, l’Io da situazioni o vissuti troppo forti o dolorosi, in questo caso dall’aggressione, identificandosi con la persona dalla quale ci si aspetta di essere aggredito. E’ una dinamica, questa, normalmente osservabile del gioco del bambino piccolo, dove l’assunzione del ruolo attivo attraverso l’identificazione con l’oggetto temuto, riesce ad elaborare il vissuto e trasformare l’angoscia in un’attività piacevole (es. Il gioco del rocchetto, Freud S., 19204).
Hartmann, Kris e Loewenstein: aggressività come fondamento della struttura psichica
Pur conservando la strutturazione della psiche in Es, Io e Super -io, Hartmann, Kris e Loewenstein (1964), ipotizzano un processo evolutivo che segue un percorso diverso da quello pensato da Freud. Essi suppongono, alla genesi dell’apparato psichico, l’indissolubilità dell’Es e dell’Io. Quest’ultimo, andrà a costituirsi pian piano attraverso l’influenza di tre fattori: quelli ereditari, quelli pulsionali e quelli provenienti dalla realtà. Il raggiungimento dell’autonomia dell’Io inoltre, richiede la presenza di una certa quantità di energia pulsionale che può essere indifferentemente di natura aggressiva, libidica o deistintualizzata, e che subisce un processo di neutralizzazione, ovvero di modifica della natura intrinseca della pulsione stessa, potendo quindi essere sfruttata dall’Io per controllare il corpo, la realtà e la formazione dell’”impalcatura” psichica.
La concezione dell’aggressività dei tre autori, prende quindi le distanze dal precedente concetto di pulsione di morte freudiano, e individua nella stessa un ruolo fondamentale per la strutturazione psichica e il funzionamento dell’Io, nonché per la successiva formazione del Super-io.
Adler e Lebovici: dalla pulsione alla risposta adattiva
Molti autori successivi o contemporanei di Freud, non accettano di vedere l’aggressività come una pulsione istintuale e innata, bensì la identificano come una risposta, una reazione ad un input ambientale specifico.
Tra questi, Adler (1908), teorico della psicologia individuale, avvicina alcuni aspetti della propria concezione alle teorie comportamentiste; lontano da considerare una reazione aggressiva come istinto o pulsione, la identifica piuttosto come “compensazione” a un’esperienza di privazione o frustrazione, una modalità di intervenire in maniera adattiva sulla realtà e non una forza negativa o distruttiva.
Lebovici5, ancora, studiando il fenomeno aggressivo nel bambino, considera queste manifestazioni come reattive non solo alle condizioni esterne e oggettive dell’ambiente, ma anche alle immagini, lentamente interiorizzate, che si vanno a costituire in base alla storia individuale di rapporto con l’oggetto.
Secondo questo autore, il comportamento aggressivo si inscrive nelle vicissitudini della comunicazione tra madre e bambino, e merita di essere esaminato sia nel quadro delle proiezioni del bambino sulla madre, sia le risposte della madre a tali proiezioni, interpretabili a loro volta come aggressive o meno. La condotta del bambino quindi, è una risposta che istituisce il comportamento dei genitori.
Kohut, e Fonagy: aggressività come reazione al mancato rispecchiamento materno
Queste precedenti riflessioni vengono abbracciate anche dalla corrente psicologica del sé che, ampliando ed elaborando la letteratura passata, considera la costruzione dell’identità personale come un processo in cui le reali relazioni affettive (primaria e successivamente con l’altro) garantendo l’empatia, l’assolvimento dei bisogni, e il rispecchiamento, ricoprono un ruolo essenziale.
Kohut (1977), vede nell’aggressività, la reazione difensiva di ferite narcisistiche determinate dal mancato rispecchiamento empatico da parte dell’oggetto sé (caregiver) nei primi anni di vita. Attraverso l’approfondimento delle comunicazioni dei suoi analizzandi e in base allo studio delle “resistenze” e delle “traslazioni negative” dei suoi pazienti, è giunto a considerare l’aggressività non come la manifestazione di una pulsione innata, ma come un risultato di disintegrazione, arcaica, ma non psicologicamente primaria del sé.
Altrettanto vicine, sono le posizioni di Fonagy, recente psicanalista londinese (1993). Riprendendo il pensiero di vari autori del passato6, egli ipotizza l’eziopatogenesi dell’aggressività come conseguenza di un mancato sviluppo di quella che lui chiama “funzione riflessiva”. Lo sviluppo del bambino prevede che egli maturi progressivamente due aspetti del sé: prima quello pre-riflessivo o fisico, legato alla sperimentazione concreta del mondo nel qui e ora, e poi, a partire dai due anni, il sé riflessivo o psicologico, capace di giudicare sé e il mondo sulla base dell’esperienza e del pensiero. Lo sviluppo della funzione riflessiva, fattore protettivo nei confronti della comparsa di comportamenti aggressivi dipende, secondo Fonagy, dalla capa cità del caregiver di creare un attaccamento sicuro con il bambino e di essere specchio, contenitore e regolatore degli stati mentali dello stesso. L’incapacità di mentalizzare e comprendere gli stati propri e altrui, può infatti spingere il soggetto a usa re il corpo (e quindi anche l’aggressività) come sostituto del pensiero.
Il contributo di D.W. Winnicott
Un ultimo e originale approccio al tema dell’aggressività, giunge da D.W. Winnicott (1896-1971). Profondamente convinto del senso ubiquitario del termine “aggressività”, egli considera la stessa come pulsione che favorisce l’autoaffermazione, la conservazione e la costruzione del sé.
Teorizzando un’interessante correlazione tra motricità e aggressività, Winnicott si avvicina molto ai principi della riabilitazione neuropsicomotoria, che trova proprio nel movimento, nel tono e nelle posture, il canale espressivo su cui lavorare. Per studiare l’insorgere dell’aggressività, l’autore si propone quindi di andare all’origine del movimento, e in particolare ai movimenti fetali e neonatali. Egli ritiene che una parte della motilità si fonda con il potenziale erotico e fornisca quindi esperienze di piacere e di soddisfazione, mentre una restante parte “ha bisogno di trovare un’opposizione, di premere contro qualcosa per non restare priva di esperienza ”, ovvero trova immediatamente un suo senso nell’aggressività e nell’opposizione.
Non c’è dunque, contrariamente a quanto si osserva nella patologia, movimento privo di esperienza, né motricità fine se stessa, ma sempre correlata all’esperienza e agli affetti. Nel sostenere come motricità e aggressività siano determinanti nell’avvio della costruzione del sé, Winnicott propone tre schemi esemplificativi: il primo schema è dato dalla continua scoperta dell’ambiente grazie al movimento, al contatto e all’opposizione ad esso; il secondo schema è caratterizzato dalla pressione dell’ambiente sul feto (o sul neonato). La motilità in questo caso è sperimentata solo come una reazione (e non interazione) all’urto dell’ambiente.
Nel terzo schema, infine, c’è totale assenza di spazio per l’esperienza individuale, e il soggetto si sviluppa come estensione dell’ambiente. “ l’individuo allora esiste per il fatto di non essere trovato”.
Il primo schema è il solo che viene definito “sano” dall’autore. Attraverso le cure materne sufficientemente buone il bambino comincerà ad esistere e a vivere le esperienze dell’Es. Negli altri due schemi, invece, il soggetto si trova in uno stato di dipendenza dalla presenza ambientale che, solo se continuerà a premere in modo continuo e strutturato, garantirà la soddisfazione dell’individuo.
Il contributo della psicanalisi nell’inquadrare con più chiarezza il fenomeno aggressivo, si è visto essere assolutamente fondamentale. Le iniziali intuizioni di Freud e della Klein, che per primi ebbero il merito di animare il bambino di pulsioni arcaiche e innate, si sono ampliate e arricchite sempre più grazie anche alle moderne ricerche scientifiche sullo sviluppo infantile, giungendo ad attribuir e un ruolo altrettanto importante alle prime relazioni affettive come fonte di esperienza che partecipa nella strutturazione psichica e nel modellare il futuro stile comportamentale del bambino.
Modelli comportamentali e sociali
Il comportamento aggressivo ha suscitato sempre più l’interesse anche delle correnti comportamentiste e sociali della psicologia. Secondo tale prospettiva esso non è un impulso naturale e innato nell’uomo, ma una forma di comportamento sociale influenzato dall’ambiente, ma che a sua volta ha effetti su chi ci circonda (Krahè, 2005). All’interno della stessa disciplina, tuttavia, si individuano, anche temporalmente, diverse correnti teoriche.
L’ipotesi frustrazione - aggressione
Dollard, Doob, Miller, Mowrer e Sears nel volume “Frustrazione e aggressività” (1939), affermano che il comportamento aggressivo di un individuo è sempre determinato dalle frustrazioni subite in precedenza vissute come un ostacolo alla realizzazione di un determinato scopo da raggiungere (evitare o ottenere qualcosa, attirare l’attenzione etc..) e che, all’inverso, la presenza di una frustrazione conduce necessariamente a qualche forma di aggressività.7
A constatare presto la limitatezza di tale argomentazione sarà già lo stesso Miller (1941), che rivedrà la teoria originale osservando come non sempre l’esistenza della frustrazione porta a qualche forma di aggressione, ma essa provocherà diversi tipi di risposta, una delle quali può essere di tipo aggressivo. E’ il modello sociale con il quale il soggetto si confronta a plasmare la tipologia di reazione, in particolare, si può dire che l’aggressività si presenterà solo qualora l’individuo avrà acquisito l’abitudine a tale comportamento. Se questa reazione porta poi a una limitazione dello stato di frustrazione si verifica un fenomeno di auto -rinforzo, per cui, in simili situazioni, si verrà a ripetere la stessa tipologia di risposta.
La teoria del social learning
A partire dagli anni sessanta, Bandura e colleghi, ampliando le precedenti intuizioni di Miller, elaborarono la teoria del social learning, secondo la quale, l’aggressività non è solo una reazione ad un disagio affettivo (o frustrazione), ma una condotta sociale suscettibile di essere appresa, analizzata in base agli stimoli che la sollecitano, in base ai rinforzi che la facilitano o inibiscono e in base al grado di determinazione o autocontrollo del protagonista dell’azione.
L’aggressività non è l’unica conseguenza possibile per uno stimolo frustrante, ma è riflesso di una determinata organizzazione sociale, all’interno della quale il soggetto osserva, seleziona, mentalizza, apprende e ripropone tratti di comportamenti elaborati.
Conferma alle ipotesi teoriche, sono gli stessi esperimenti di Bandura (1963) che osservarono come, bambini a cui era mostrato il video di un adulto che colpiva un pupazzo, tendevano a riproporre poi nel gioco la stessa modalità di approccio allo stesso oggetto. Esperimenti successivi condotti da Kuhn, Madsen e Becker (citati in Caprara e Renzi, 1985)8, che confrontano le reazioni di soggetti sottoposti a frustrazione con i gruppi di controllo, confermano che la frustrazione non stimola l’aggressività più di quanto non accada anche nei soggetti non frustrati, ma sottoposti ad altri tipi di stimoli, e che questa è piuttosto strettamente connessa ai processi di apprendimento.
Si prende atto che la persona sta in continua interazione e reciprocità con l’ambiente, e che ogni condotta quindi va colta nella sua specificità e contestualità. Capire il perché di un certo comportamento, significa cogliere i modi con cui esso è entrato a far parte del repertorio del soggetto, intuirne i significati e gli effetti, comprenderne le possibilità di modifica modificando tali significati; significa, in sintesi, analizzare con cura il contesto sociale in cui esso è inserito.
Fight or flight: L. Berkowitz e i contributi della neurofisiologia
Secondo il modello del neoassociazionismo cognitivo di Berkowitz (1989), che deriva dalla revisione della bibliografia precedente, un soggetto sottoposto ad un evento negativo (frustrazione, dolore, rabbia, paura), può attivare due possibili reazioni impulsive contrapposte, attacco o fuga (fight or flight) giustificate anche da ricordi e reminescenze passate; solo una successiva elaborazione delle circostanze, permette il passaggio ad uno stato emotivo più complesso e alla risposta comportamentale più adeguata. L’aggressività non è quindi un tratto innato del comportamento umano, ma una sua caratteristica che può essere attivata o soppressa dall’esperienza derivante dal contesto ambientale (esterno e interno).
A conferma alla teoria di Berkowitz, giunge anche il contributo della neurofisiologia. La reazione automatica e stereotipata del tipo fight or flight di fronte alla percezione di un pericolo, è giustificata infatti dall’attivazione del sistema nervoso autonomo ortosimpatico che, attivando varie funzioni neurovegetative ed endocrine (secrezione di adrenalina, noradrenalina, cortisolo, contrazione muscolare, aumento della sudorazione e della frequenza cardiaca) in corrispondenza di una situazione realmente o potenzialmente stressogena, consente all’organismo di affrontare l’allarme, ma tale reazione, verrà poi compensata dall’attività dei centri superiori, che, in accordo ad una più accurata valutazione della situazione, attiveranno un tipo di risposta più adeguata ed elaborata.
L’influenza del contesto sociale
Studi più recenti hanno indagato come l’ambiente sociale o familiare, potesse effettivamente ricoprire un ruolo fondamentale nello sviluppo del bambino, e come le caratteristiche dello stesso si riflettono poi nella maturazione dei tratti comportamentali.
In particolare si rilevano quattro fattori di rischio principali per lo sviluppo di disturbi del comportamento: la privazione economica, la disorganizzazione familiare o sociale, il livello di brutalità o violenza familiare o sociale, e la demoralizzazione del gruppo sociale considerato (Currie E.).
Numerosi studi che hanno confrontato bambini che vivono in un ambiente sociale definito “a rischio” con gruppi di controllo, sono giunti a conferma di tali ipotesi. Fuller, Thomson e Lewis (2015) dimostrarono il legame tra la violenza e gli abusi subiti nell’infanzia e la successiva diagnosi di ADHD 9.
McFarlane (2003) prova che figli di madri vittime di violenze in famiglia riportano una percentuale significativamente più alta di disturbi del comportamento internalizzanti o esternalizzanti,rispetto al gruppo di controllo.
Gerardin et al. (2000) sostengono che situazioni di abuso, criminalità o svantaggio sociale e familiare sono fattori di rischio per lo sviluppo in generale di varie tipologie di condotte aggressive. Condizioni di svantaggio socio economico, predisporrebbe infine, i bambini a un più alto rischio di sviluppare problemi comportamentali di tipo esternalizzante (Dearing, McCartney, & Taylor, 2006).
In conclusione si può dire che la condotta aggressiva è sempre l’esito di una serie di fattori interni ed esterni, che interagiscono e si integrano reciprocamente, tali per cui talvolta il fattore di maggior suscettibilità è la frustrazione, talvolta il presupposto si rivela essere uno stato di conflitto dinamico o di eccitazione emotiva. Certo è che non si può affrontare il tema dell’aggressività riducendolo al comportamento aggressivo, come non si possono escludere a vicenda le ipotesi costituzionale e reattiva, ma, consapevoli della compresenza di entrambi i fattori, si ritiene necessario valutarla nella sua eterogeneità di espressione e significati.
Modello etologico
L’etologia, traendo origine dal postulato secondo cui l’adattamento filogenetico determina il comportamento dell’individuo (umano o animale), studia lo stesso all’interno del suo ambiente naturale e nelle sue relazioni con gli individui della stessa specie o di specie diversa.
Il maggior esponente della teoria etologica fu sicuramente K. Lorenz, che definisce l’aggressività come un istinto primario e naturale, al pari della fame o del desiderio sessuale, al servizio della vita, della sopravvivenza e della conservazione della specie.
Lo studioso distingue oggettivamente due tipi di aggressività, quella interspecifica e quella intraspecifica: la prima palesemente finalizzata alla conservazione della specie (ricerca del cibo per la sopravvivenza), la seconda ai fini di difendere il territorio, contendersi la femmina, o affermarsi all’interno della gerarchia sociale. L’etologo, quindi, non si limita a descrivere il tipo di comportamento, ma piuttosto considera fondamentale il fattore intenzionalità. Secondo questa prospettiva, l’aggressività interspecifica non può dirsi tale in senso stretto, in quanto non finalizzata a fare del male (secondo Lorenz “Il cane che si slancia sulla lepre colmo di passione venatoria, fa esattamente la stessa faccia, fra l’ansioso e il felice, con la quale saluta il padrone”), mentre può considerarsi aggressiva solo la condotta indirizzata verso la stessa specie, poichè intenzionale e sottesa da un impulso biologicamente adattivo e anch’essa, seppur in modo diverso, mossa dal fine di conservativo.
Indipendentemente dalla funzione che svolge, l’aggressività per Lorenz è un’energia, un istinto, che in quanto tale può rivelarsi pericoloso. Necessita quindi di essere periodicamente scaricato all’esterno in modo meno distruttivo possibile, cioè attraverso processi di ri-direzionamento.
“La ri-direzione dell’attacco è l’espediente più geniale che l’evoluzione abbia inventato per costringere l’aggressività su binari innocui” (Lorenz K. “Il cosiddetto Male”1963)
L’aggressione intra-specifica, orientando la distribuzione del territorio, proteggendo la prole, e organizzando la scala sociale, non ha evidentemente come scopo ultimo l’eliminazione della stessa specie, bensì la conservazione e il raggiungimento del bene. La pericolosità degli atti aggressivi è infatti enormemente contenuta da quella che Lorenz chiama “ritualizzazione”. Essa è definita come a una serie di comportamenti stereotipati di sottomissione e pacificazione che provocano nell’aggressore l’inibizione della spinta aggressiva, con notevole vantaggio per la conservazione della specie.
Questo primo meccanismo inibitore costituisce anche una prima forma di comunicazione e collaborazione reciproca. Scrive infatti l’etologo: “ Un vincolo personale, un’amicizia individuale, si trovano solo negli animali con un’aggressività intra-specifica altamente sviluppata, anzi questo vincolo è tanto più saldo quanto più aggressiva è la rispettiva specie animale.” L’aggressività è dunque filogeneticamente ben più antica dell’amore, è anzi, la condizione primaria che ne permette l’affermazione.
Concezione questa, che trova in parte conferma anche nelle teorie psicodinamiche, secondo le quali il processo di legare sé all’altro, avviene solo secondariamente attraverso la libido, ma è preceduto piuttosto dalla tendenza aggressiva che fa leva su ciò che è prima minaccioso e ostile e poi anche attraente.
Ai fini di frenare l’attacco aggressivo, gli etologi hanno rilevato alcuni particolari tratti morfologici o comportamentali dati da determinati atteggiamenti mediante i quali l’individuo riconosce la superiorità del nemico e cessa il combattimento mostrandogli ad esempio il suo punto debole, collocandosi in posizione di sottomissione sessuale, o mostrandogli i suoi organi genito-urinari.
Il confronto con l’uomo
Non è sempre corretto però sovrapporre le considerazioni effettuate sugli animali all’uomo.
E’ possibile ritrovare alcune analogie considerando, ad esempio, come determinate posture o atteggiamenti rivolti all’aggressore, possono talvolta effettivamente inibire anche nell’uomo la condotta aggressiva. Ciò si rende particolarmente evidente con alcuni bambini gravi che in terapia mettono in atto comportamenti di questo tipo e con cui un particolare assetto posturale della terapista con tono muscolare basso, può facilitarne la modulazione, e il rientro dall’atto.
Anche i processi di ri-direzionamento si attuano continuamente nell’uomo e nel bambino. Ne sono un esempio tutti i giochi di lotta o distruzione, in cui l’aggressività simbolica diretta all’oggetto, reale o simbolico, diventa un importante canale di sfogo.
Il problema dell’aggressività umana, secondo Lorenz, emerge però dal fatto che mancano molti di questi meccanismi inibitori; il comportamento aggressivo diventa fine se stesso, perdendo il fine autoconservativo e sfociando piuttosto distruttività intraspecifica.
Bonino e Scaglione10 individuano come possibile causa della difficoltosa ritualizzazione dell’aggressività, la plasticità tipica dell’uomo, che non si limita ad agire secondo schemi e istinti programmati come l’animale, ma si lascia plasmare e influenzare in modo ridondante dall’ambiente.
I recenti studi sulla plasticità neuronale ne sono un’ulteriore conferma. La corteccia cerebrale dell’uomo, infatti, specialmente in età precoce, si presta ad adattarsi con flessibilità agli eventi esterni, per rispondere in maniera sempre più adattiva agli stimoli ambientali, e promuovendo quindi l’apprendimento.
Non a caso in alcune patologie quali l’autismo, in cui fra l’altro il soggetto mostra notevoli problematiche di apprendimento e adattamento, è fortemente presente il bisogno di mantenere l’equilibrio interno, ritualizzando eventi e contesti in chiari schemi prevedibili.
L’etologia ci mostra che nel regno animale, le componenti e le attività aggressive e difensive, si manifestano in modi molto differenziati, che nascono da precise intenzionalità, ma possono anche essere limitate attraverso chiari meccanismi d’inibizione. Si è visto che molti di questi aspetti possono, almeno in parte, coincidere con ciò che normalmente vediamo anche nell’uomo e nel bambino, ma che in esso, più che in qualsiasi altra specie, si esplica l’eccezionale intersezione dei fattori ambientali e genetici, tali da determinare l’unicità e la complessità espressiva del comportamento.
Aspetti neuroanatomici
Dall’indagine dei substrati neurofisiologici avvenuta tramite processi di ablazione chirurgica o di lesione cerebrale associata o meno a terapia farmacologica risulta come, nelle condotte aggressive dell’animale, siano effettivamente coinvolte varie aree cerebrali, dal sistema olfattivo e dalla corteccia prepiriforme all’amigdala, dall’ipotalamo ai nuclei del rafe.
Lo studio di modelli animali quale il gatto o il topo, le cui strutture neurofisiologiche riportano notevoli somiglianze con quelle umane, ne ha reso possibile il confronto ai fini di individuare i meccanismi che portano all’attivazione o all’inibizione delle condotte aggressive. E’ possibile innanzi tutto, in accordo alla teoria etologica, distinguere il comportamento aggressivo in due categorie: offensivo e difensivo.
Nel gatto, la struttura coinvolta sia nelle condotte reattive, che in quelle attive è prevalentemente l’ipotalamo. Rispettivamente, nel primo caso sono il nucleo mediale insieme alla porzione dorsale della sostanza grigia periacqueduttale che si attivano, nel secondo caso la porzione laterale perifornicale dell’ipotalamo stesso.
In dettaglio, il comportamento non direttamente legato all’offesa (es. mordere) è guidato dalle fibre che dall’ipotalamo laterale si dirigono verso il nucleo settale, il talamo mediale, la regione perifornicale e in parte quella segmentale-ventrale del tronco encefalico, mentre il sito di ancoraggio che guida la genesi del comportamento di attacco origina un fascio di proiezioni che si estende dall’ipotalamo perifornicale verso l’area settale, la stria terminale, il locus caeruleus e il nucleo motorio del nervo trigemino. L’attivazione dell’area mediale preottica e la porzione dorsale della sostanza grigia periacqueduttale mesencefalica, sono invece nel felino, responsabili dell’attivazione delle risposte fisiologiche di tipo difensivo (Fuchs et al., 1985).
Le strutture cerebrali deputate invece alla modulazione e inibizione delle risposte aggressive sono senz’altro l’amigdala, per la valutazione del pericolo e per l’apprendimento e l’organizzazione del comportamento in seguito alla paura, l’ippocampo, il talamo, il giro del cingolo, il bulbo olfattivo e la corteccia prefrontale.
Diversi studi effettuati sia su campioni animali che umani, si occuparono di definire in particolare il ruolo dell’amigdala, della corteccia e del rapporto tra le due; l’amigdala riceve input infatti, da due vie, quella talamica, grezza e non elaborata, e quella corticale più tardiva ma più completa. Entrambi gli input, sebbene in tempi diversi, raggiungono gli stessi neuroni, che se vengono attivati dall’amigdala per via talamica, non possono essere attivati dalla corteccia e viceversa (rapporto di antagonismo funzionale reciproco). Così l’attivazione nervosa dell’amigdala, che esclude la mediazione corticale, espone il soggetto al rischio di compiere “errori emotivi” di fronte a uno stimolo esterno.
Lo studio di quattro campioni di ratti, uno con lesione all’amigdala centrale, uno all’amigdala basolaterale uno all’amigdala mediale e l’ultimo gruppo di controllo, suggerisce che le porzioni centrali e basolaterali sono responsabili dell’apprendimento del pericolo, mentre la valutazione oggettiva del pericolo stesso, è da deputarsi alla lesione in porzione mediale (Oakes e Coover, 1997)11.
Il ruolo modulatorio della corteccia è stato poi dimostrato in più studi, in cui si osserva che soggetti con ridotta attivazione dei siti ipotalamici ma soprattutto delle efferenze della corteccia prefrontale all’amigdala (ad esempio in seguito ad un trauma cranico o a un danno frontale), mostravano comportamenti iperaggressivi sia di attacco che di difesa come conseguenza a una sopravvalutazione del pericolo.
Circa l’inibizione del comportamento aggressivo per mezzo della stimolazione elettrica di aree cerebrali, una riduzione drastica dell’aggressività viene riportata a seguito della stimolazione dell’area settale e dopo stimolazione continua della porzione rostrale del verme cerebellare, mentre altri studi riportavano l’effetto sedativo della stimolazione della porzione ventro-mediale del lobo frontale o del lobo medio temporale.
I correlati clinici di quanto sopra esposto trovano ragione soprattutto nella vasta letteratura che tratta del disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività (ADHD).
In questi bambini, infatti, si rende evidente spesso un deficit alle strutture corticali prefrontali che dovrebbero regolare i comportamenti, l’espressione emotiva, l’attenzione, la motivazione e la capacità di giudizio. Nella clinica il bambino si presenta infatti, impulsivo, facilmente distraibile o in difficoltà ad inibire i comportamenti inadeguati.
Rispettivamente alla regolazione delle emozioni e del comportamento più in generale, altri studi condotti sia su pazienti ADHD adulti che bambini, hanno riscontrato una riduzione del volume dell’amigdala destra o un anomalo funzionamento della stessa, con conseguente incapacità di controllo degli impulsi e problematiche nel processamento dell’informazione emotiva (Tajima-Pozo et al., 2015)12; anche anomalie morfologiche a livello dell’ipotalamo e della corteccia prefrontale si rendono responsabili, tra l’altro, di comportamenti aggressivi non pianificati e non finalizzati.
Al di là della diagnosi clinica, si evince quindi, che dal punto di vista neuroanatomico, il comportamento aggressivo è associato principalmente a strutture quali l’ipotalamo, l’amigdala e alla corteccia prefrontale (Van Elst et al 2000, Damasio et al 1994).
La scarsa “intelligenza emotiva strategica”, che si evidenzia in seguito a un’iperattivazione dell’amigdala e un’ipoattivazione della corteccia, costituisce la base del problema dell’aggressività impulsiva, in quanto non permette al soggetto di comprendere oggettivamente lo stato emotivo altrui, né di gestire, di conseguenza, le proprie emozioni (Coccaro, 2015).
Si deduce che l’informazione non viene processata dalla corteccia, o viene processato in modo distorto, non subisce un’elaborazione conscia e ponderata, ma, senza poter essere controllata, passa immediatamente all’amigdala il cui nucleo centrale attiva prontamente il sistema difensivo.
Solo la corretta attivazione e sinergia delle due strutture che ricevono ed elaborano l’informazione, permetterà la formulazione di una risposta comportamentale quanto più adeguata possibile al contesto.
Aggressività e specializzazione emisferica
Interessante appare il concetto di specializzazione emisferi ca, in quanto un crescente numero di dati specifica che i due emisferi elaborano informazioni e forniscono risposte in modo differenziale e complementare; i lobi frontale e parietale sinistro, in particolare, elaborano in modo più efficace del destro un’attività verbale, mentre per l’attività non verbale avverrebbe l’opposto. Parallelamente, studi neuropsicologici indicano che i due emisferi cerebrali apportano un differente contributo alle manifestazioni emotive. L’emisfero destro sarebbe in maggior misura implicato nelle esperienze emozionali, specialmente negative, nella valutazione dell’informazione spaziale e nelle condotte istintive, il sinistro, invece, sarebbe maggiormente chiamato in causa nelle attività cognitive, nelle condotte intenzionali, logiche e analitiche. L’emisfero destro, dunque, dovrebbe essere particolarmente coinvolto in esperienze tipicamente affettive ed emozionali, come ad esempio la depressione, l’ansia o l’aggressività (Costanzo et al., 2015).
Nell’uomo, per lo studio neuroanatomico delle strutture coinvolte in alcuni stati emotivi quali l’aggressività, possono essere utili i dati estratti dallo studio di soggetti epilettici.
A conferma di quanto precedentemente esposto, nell’epilessia temporale destra è stata riportata una preponderanza di disturbi aggressivi e dell’umore, con un patt ern aggressivo di tipo “impulsivo”, mentre in quella sinistra sono più frequenti i disturbi del pensiero e valenze aggressive di tipo “riflessivo” (Toller, 2015; Boulogne, 2015). Mentre l’emisfero destro sarebbe coinvolto maggiormente nelle risposte di tipo affettivo-emozionale, impulsive e di vigilanza, il sinistro lo sarebbe in quelle di tipo razionale, riflessivo. Pertanto, si potrebbe ipotizzare che l’iperattivazione dell’emisfero destro sia il substrato neurofisiologico del comportamento aggressivo, anche in ragione dell’aumento dell’effetto frustrante degli stimoli negativi determinato dalla loro ipervalutazione da parte dell’emisfero iperfunzionante. L’analisi dell’elettroencefalogramma (EEG), correlata alla compilazione di questionari comportamentali, conferma la relazione positiva tra profilo dell’aggressività e indice di asimmetria: tanto più il comportamento aggressivo si presenta inibito, tanto più vi è una predominante attivazione sinistra nella regione temporale medio-posteriore e frontale anteriore. All’opposto, ad un aumento dell’aggressività agita, corrisponde una minore attività a sinistra nelle stesse sedi. Bisogna tuttavia considerare che il metodo di analisi tende ad evidenziare i rapporti dell’attività di alcune aree rispetto ad altre, piuttosto che il reale grado di attivazione (Domracheva, 2011).
Le preponderanze funzionali, suscettibili anche delle differenze inter- e intra- individuali, sono sinergicamente integrate dalle connessioni interemisferiche create dal corpo calloso e dalle commessure. Non si può dunque, considerare queste specializzazioni come demarcazioni assolute; i principi della plasticità cerebrale, inoltre, contribuiscono a rinforzare la tesi secondo la quale il nostro cervello non si presta ad essere materia statica e immutabile, ma in continua interazione con gli stimoli ambientali che la modellano e la modificano.
Aspetti neurochimici
Lo studio dei componenti biochimici e neurotrasmettitoriali alla base del comportamento aggressivo nell’uomo, derivano dai precedenti approfondimenti sugli animali i quali hanno indirizzato la ricerca soprattutto verso l’analisi della neurotrasmissione serotoninergica, dopaminergica e noradrenergica.
Il sistema serotoninergico
La serotonina, svolge una funzione principalmente regolativa dell’umore, dell’attività motoria, cognitiva, sensoriale, omeostatica ed esecutiva. Non sorprende, dunque, il fatto che un deficit nell’attività serotoninergica sia alla base di numerosi disturbi neuropsichiatrici, molti dei quali associati all’ansia (disturbo depressivo, disturbo del comportamento alimentare, disturbo dell’attenzione).
Il sistema d’interazione neurotrasmettitoriale in cui la serotonina svolge sia ruoli inibitori che eccitatori, è prevedibilmente molto complesso poiché non regola soltanto un comportamento o attività specifica, ma svolge una funzione modulatoria più generale.
Nonostante i numerosi studi effettuati con lo scopo di individuare la relazione tra l’attività serotoninergica e l’aggressività riportassero risultati talvolta contrastanti tra loro, sembra ormai assodato che una minor presenza del neurotrasmettitore riduca la possibilità di comunicazione tra le diverse regioni del cervello deputate alla regolazione emotiva, e in particolare compromette la capacità della corteccia prefrontale di controllarne la risposta, aumentando di fatto la possibilità che l’individuo non sia in grado di mediare all’impulso aggressivo (Perrier, 2014; Passamonti, 2012; Lesch, 2000). Particolarmente esplicativi, sono in questo senso gli studi effettuati su bambini e ragazzi con ADHD, i quali hanno evidenziato un’alternazione del funzionamento della serotonina come fattore causale dell’aumento di comportamenti aggressivi soprattutto di tipo impulsivo (Zepf, 2008; Helperine, 1997).
Il sistema dopaminergico
Anche la dopamina è coinvolta nella gestione dei comportamenti aggressivi, essendo implicata nelle funzioni di processamento cognitivo e decision making, nella motivazione, nell’attenzione, nell’apprendimento, nella coordinazione motoria, nonché nel circuito del piacere e della gratificazione.
Studi condotti sui ratti, hanno individuato una stretta relazione tra diminuzione di dopamina del mesencefalo, ippocampo e corteccia prefrontale, e maggior propensione verso un comportamento aggressivo . In accordo con i risultati ottenuti nei successivi studi sull’uomo (Schluter et al., 2013), pare quindi che una maggior disponibilità di dopamina nei circuiti neuronali, possa incrementare le capacità cognitive del soggetto, così da mitigare le possibili risposte aggressive disadattive.
Ridotte concentrazioni di dopamina, sono state riscontrate nelle analisi post-mortem dei cervelli di persone con sindrome di Lesh-Nyhan (sindrome genetica caratterizzata da ritardo mentale associato a gravi condotte autolesive), così come in soggetti depressi, autistici, o con ADHD. In essi, l’insufficiente trasmissione dopaminergica, si traduce in incapacità di processamento degli stimoli ambientali, di programmare il repertorio motorio e comportamentale e nella capacità di autocontrollo, ad ulteriore conferma di quanto vasto sia il raggio d’azione di questo neurotrasmettitore e di quanto, ancora una volta, aspetti più strettamente cognitivi ed esecutivi siano connessi a quelli emotivi.
Il sistema noradrenergico
La noradrenalina ricopre un ruolo fondamentale nella regolazione dei cicli sonno - veglia, nella memoria, nell’inibizione endogena del dolore e nella reazione di attacco-fuga di cui si è precedentemente esposto.
Svolgendo il ruolo sia di neurotrasmettitore che di ormone dello stress, essa viene rilasciata dai neuroni post-gangliari dell’ortosimpatico e dalle ghiandole surrenali, in presenza di un forte stress psicofisico e attiva, insieme all’epinefrina e all’adrenalina, e grazie alla connessione con l’ipotalamo, tutte le risposte fisiologiche di attacco o fuga (aumento della frequenza cardiaca, della sudorazione, del tono muscolare etc..) che portano il soggetto in una condizione di “surplus” di energia tale da renderlo reattivo alla potenziale o reale situazione di pericolo.
I sistemi serotoninergico, dopaminergico e noradrenergico, regolano dunque molteplici aspetti del comportamento. Le loro azioni ad ampio raggio che coinvolgono le diverse strutture cerebrali, permettono al soggetto di regolare il proprio stato emotivo, il controllo esecutivo, la motivazione e le risposte motorie.
Gli studi futuri, approfondiranno sempre meglio il ruolo che questi neurotrasmettitori hanno anche nel modulare le condotte aggressive, ampliando di conseguenza lo studio e la ricerca circa il trattamento farmacologico dell’aggressività.
l ruolo delle endorfine
Le endorfine sono sostanze classificate come neurotrasmettitori. Prodotte nell’ipofisi e notevolmente presenti e attive a livello cerebrale, esse sono coinvolte in molte funzioni cognitive complesse tra cui la regolazione dell'attenzione, la perce zione del dolore, I'affettività, il comportamento sociale e I'organizzazione motoria.
Una disfunzione del metabolismo delle endorfine è stata quindi messa in rela zione con l’eziopatogenesi di alcuni disturbi emotivi ed affettivi come l'autismo infantile (Weizman et al., 1984), o alla base di alcune disfunzioni comportamentali come l’autolesionismo.
La maggior parte delle funzioni alterate nel soggetto autistico, sono infatti controllate da aree del cervello in cui sono state notate alte concen trazioni di questi oppioidi endogeni.
I bambini autistici risultano infatti essere meno sensibili al dolore, meno emotivi, piangono di meno, risultano meno adeguati sul piano relazionale e manifestano inol - tre un'estrema resistenza all'estinzione dei pattern comportamentali patologici (Barron e Sanderman, 1983).
Esperimenti condotti sugli animali hanno dimostrato come dal trattamento con elevate dosi di oppioidi endogeni emergessero sintomi quali: a) insensibilità al
dolore; b) diminuzione delle vocalizzazioni; c) scarsa tendenza all'esplorazione; d) ridotte capacità di socializzazione; e) episodi di aumento di attività motoria alternati a periodi di rilassamento; f) labilità emotiva; g) comportamento stereotipato e ripetitivo (Panskepp, 1979).
L’ipotesi secondo cui il comportamento autolesionistico derivi da una possibile insensibilità al dolore dovuta ad un’eccessiva presenza di queste sostanze, è supportata dalle indagini di Gillberg (1995), che rilevò livelli di endorfine nettamente superiori rispetto alla norma in bambini autistici con manifestazioni autolesionistiche. La relazione tra i due fattori può essere spigata da diverse teorie:
- L’eccessiva quantità di oppioidi sopprime la sensibilità al dolore e permette quindi il verificarsi dell’autolesionismo;
- E’ l’intensa attività autostimolatoria a scatenare il rilascio di endorfine, che a loro volta stimolano i centri del cervello, rinforzando così il comportamento;
- L’aumento di oppioidi endogeni può stimolare l’aumento di comportamenti stereotipati, alcuni dei quali risultano autolesivi.
Non è ancora unitariamente provato quale di queste ipotesi sia quella valida, ma è molto probabile, che alla base del comportamento autolesivo, ci sia una combinazione di questi tre meccanismi, che si influenzano e rinforzano a vicenda e che si intersecano a loro volta con l’azione degli altri agenti chimici di cui si è in precedenza descritto il funzionamento.
Aggressività e funzioni esecutive
Il ruolo della corteccia prefrontale come modulatrice delle risposte aggressive, è stato largamente accertato da numerosi studi effettuati sia sugli animali che sull’uomo, i quali hanno attribuito soprattutto alla zona orbitale della stessa, la funzione di regolatrice degli impulsi aggressivi. La stretta interrelazione tra questa regione corticale e il comportamento aggressivo è da imputare soprattutto all’importante ruolo adattivo delle funzioni esecutive.
Le funzioni esecutive (FE) sono “l’insieme dei processi necessari a programmare, mettere in atto e portare a termine con successo un comportamento ada ttivo e finalizzato ad uno scopo” (Wellsh e Pennington, 1988).
Rientrano in tale definizione le abilità meta cognitive quali controllo inibitorio, memoria di lavoro, flessibilità cognitiva, pianificazione, controllo attentivo e autoregolazione/automonitoraggio (cold fe), importanti per affrontare compiti cognitivi quotidiani, nonché le funzioni di autoregolazione e automonitoraggio necessari per la gestione degli aspetti emotivo-affettivi (hot fe). Se ne deduce quindi che le FE regolano tutti i tratti del comportamento che permettono al soggetto di comprendere, pianificare ed elaborare gli stimoli ambientali in modo da risponderne in maniera quanto più adattiva possibile.
Anatomicamente le FE sono collocate a livello proprio della corteccia prefrontale e dei circuiti sottocorticali. In particolare le cold FE si collocano nella porzione dorso laterale della corteccia prefrontale (che consente di manipolare informazioni verbali o visuospaziali), nella zona ventrolaterale (che le mantiene in memoria), nella porzione inferiore (che consente l’inibizione della risposta comportamentale) e nel giro frontale superiore (responsabile della selezione e della flessibilità del compito); le hot FE sono connesse con il circuito ventro-mediale che riceve afferenze dal sistema emozionale limbico, dall’amigdala e dall’area tegmentale ventrale, e permettono l’elaborazione emozionale degli stimoli, la definizione della valenza emotiva, la regolazione emotiva, l’inibizione di pensieri impulsivi, l’apprendimento di comportamenti nuovi in base al contesto, le associazioni tra stimolo e ricompensa, la comprensione delle informazioni emotive e l’elaborazione di risposte adattive adeguate.
Vari studi hanno ricercato la correlazione tra deficit esecutivo, comportamento aggressivo e metabolismo prefrontale. In particolare uno studio condotto nel 2003 da un gruppo di medici dell’università di Pittsburg su soggetti con disturbo della personalità borderline o antisociale, mette in evidenza come il campione clinic o manifestasse contemporaneamente scarsa regolazione dell’impulso aggressivo, deficit nelle funzioni esecutive, ed esame PET che indicava un metabolismo prefrontale molto basso13.
Più recenti indagini sull’autismo, hanno individuato poi nello specifico, lo stretto legame tra aggressività e shifting cognitivo. Secondo Visser (2014), fattore di rischio per la comparsa di sintomi aggressivi in bambini autistici, non è tanto la disabilità intellettiva in sé, quanto la povertà di strategie cognitive.
Le FE, quale sistema di sottoprocessi distinti, ma sottilmente correlati fra loro, avviano e monitorano pensieri e azioni, giungendo a portare a termine un comportamento finalizzato.
Indissolubilmente legato a tali processi è però anche il sistema emozionale, che influenza inevitabilmente qualsiasi prestazione cognitiva. La conferma di tali ipotesi giunge anche dagli studi delle neuroscienze, che hanno riconosciuto molteplici corrispondenze neurologiche tra le aree cerebrali implicate nelle due funzioni. Calkins e Marcovitch (2010) hanno osservato che la corteccia prefrontale e la porzione anteriore della corteccia cingolata sono contemporaneamente implicate sia nel controllo esecutivo sia nell’espressione emotiva. Inoltre, Campos (2004), ha sottolineato come alcune porzioni del cervello responsabili della produzione di emozioni negative (come ad esempio l’amigdala), possano contrastare l’acquisizione e la maturazione di molti processi cognitivi, tra cui il controllo esecutivo.
Il delicato equilibrio che si crea tra i due sistemi è quindi, condizione necessaria affinchè il soggetto possa automonitorare il comportamento e adattarlo in funzione dello scopo, è cioè alla base della capacità di autoregolazione, capacità che tanto risulta inadeguata nei bambini con disturbo dello spettro autistico, con disturbo da deficit di attenzione e iperattività, o con disturbo oppositivo – provocatorio, per i quali è stato, tra l’altro verificato, un deficit nel controllo esecutivo (Kriete et al. 2015).
Si deduce, da quanto esposto, che l’intervento neuropsicomotorio, lavorando contemporaneamente sui fronti cognitivo ed emozionale, e mantenendo sempre una modalità d’approccio globale, si presta ad essere la cornice migliore all’interno della quale far maturare il processo di autoregolazione del comportamento e modificare e trasformare i modi dell’azione del bambino.
Aggressività e disturbi dell’integrazione sensoriale
“L’integrazione sensoriale è il processo di organizzazione degli in put sensoriali interni ed esterni in modo che il cervello produca una risposta utile a livello corporeo, percettivo, emozionale e intellettivo unendo tutti gli impulsi sensoriali.” (Ayres, 1972)14.
Lo sviluppo dell’integrazione sensoriale, avviene spontanea mente, attraverso un graduale processo di riconoscimento, adattamento e assimilazione del cervello alle esperienze ambientali, che permette al soggetto di poter pianificare prima e attuare poi, una risposta adattiva coerente e proporzionata allo stimolo sensoriale. La possibilità di integrare e organizzare le informazioni sensoriali , sta alla base della maturazione di tutte le componenti di sviluppo del bambino. Non appena raggiunta tale capacità, è infatti possibile una miglior organizzazione di molte altre abilità complesse, dalla coordinazione grosso e fino motoria, al controllo delle proprie emozioni e del comportamento, fino alla gestione delle relazioni interpersonali.
Il processo di integrazione si avvia quando sono soddisfatti almeno due requisiti: un’adeguata stimolazione dei sistemi sensoriali (uditivo, vestibolare, propriocettivo, tattile e visivo) che sollecita l’attivazione del soggetto e un buon flusso di impulsi dai recettori al cervello. Prosegue poi man mano che il bambino, inserito in un ambiente rassicurante e “sufficientemente buono”, matura stabilità e sicurezza emotiva, anch’esse alla base dell’organizzazione del mondo interno.
Le abilità percettive sempre più raffinate, portano il soggetto a strutturare la propria immagine corporea, a integrare l’uso di entrambi gli emisomi in azioni elaborate e attentamente pianificate secondo i parametri spazio-temporali.
Tutte le abilità, comprese quelle comunicative e relazionali, diventano poi, sempre più intenzionali, stabili e coerenti, perché fondate su un’interpretazione del mondo
data da esperienze sensoriali a loro volta integrate, interconnesse, e memorizzate dal cervello. Quando l’input sensoriale non è integrato o appropriatamente organizzato, si possono evidenziare disturbi di vario tipo nell’elaborazione delle informazioni e nella regolazione del comportamento, delle relazioni e dell’apprendimento.
In molti disturbi del neurosviluppo, come ad esempio l’autismo, la disprassia, o il disturbo del comportamento, si può ritrovare alla base u n problema di integrazione sensoriale, causato a sua volta da un’ipotetica disfunzione a livello delle interconnessioni neurali. Non è difficile, quindi, associare la difficoltà di integrare o inibire l’input sensoriale, alle alterate reazioni del tipo fight or flight (Miller, 2010) che possono sfociare poi in manifestazioni aggressive, sia etero che auto-dirette (Gunn et al., 2009); vari studi infatti, indicano una correlazione tra difficoltà a modulare e integrare le informazioni sensoriali e disturbi del comportamento esternalizzanti (Mangeot et al, 2001, Parush et al 1997). Connessione che si osserva anche a livello anatomico, per cui bambini con vari disturbi del comportamento e bambini con accertato disturbo dell’integrazione sensoriale, riportano ugualmente anomalie a livello del cervelletto, il quale, oltre che alla regolazione dei movimenti fini e dell’equilibrio, è ipotizzato essere responsabile anche della ricezione,modulazione e discriminazione sensoriale (Kern, 2002).
Per quanto riguarda i soggetti autistici, le teorie della disfunzione sensoriale nell’autismo di Delacato (1974), confrontate con numerosi studi, mostrano che una percentuale tra il 70% e il 96% di questi bambini risulta essere ipo- o ipersensibile agli stimoli sensoriali. (Marco et al., 2011). Comportamenti etero, o più spesso autolesivi, sembrano rappresentare quindi, delle strategie di difesa al sovraccarico di informazioni sensoriali al quale sono spesso sottoposti, oppure essere all’opposto delle modalità di autostimolazione, per ricercare la soglia ottimale di attivazione (aurosal), che in questo caso può essere anormalmente elevato.
La terapia neuropsicomotoria, attraverso l’attenta osservazione delle modalità del bambino e del suo canale sensoriale privilegiato, utilizza la sensorialità come strumento del lavoro, facilitando nei bambini gravi, il passaggio dalla stessa , alla percezione, in maniera graduale e progressiva, giungendo a stabilire una maggior tolleranza allo stimolo esterno, una sempre più precisa integrazione del le informazioni sensoriali, e quindi a rinforzare l’identità personale e corporea.
L’aggressività nello sviluppo tipico
I dati raccolti dalla psicologia, dall’etologia e dalla neurofisiologia, ci mostrano come, sia che venga considerata uno stato passeggero, sia uno stadio dell’evoluzione individuale, l’aggressività fa parte della vita dell’uomo, e fin da piccolissimo il bambino manifesta comportamenti o azioni aggressive con lo scopo di promuovere l’esplorazione, l’autonomia e la relazione. L’aggressività però, è anche un impulso da educare, in quanto, se mal gestita, può diventare distruttiva per sé e per gli altri: il bambino deve imparare a riconoscere dentro di sé determinate emozioni, a darne un nome, e a trasformare l’azione in pensiero, perché solo così potrà accettarlo e controllarlo.
Anche nel contesto di una normalità psicofisiologica, esistono quindi forme di reazioni aggressive immediate, differite o socializzate, e anche l’auto -aggressività, considerata per lungo tempo patologica, esiste durante lo sviluppo del bambino sano.
I comportamenti auto-aggressivi
Shentoub e Soulairac (1961) hanno a lungo studiato le condotte auto -mutilanti evolutive, suddividendole in condotte primitive e condotte strutturate e orientate. Le prime, molto frequenti fino ai due anni, si esplicano in atti di mordersi, graffiarsi, gettarsi per terra, e fungono, da mezzi di adattamento, esplorazione, strutturazione di sé e soddisfazione autoerotica. Tra le condotte strutturate, invece, ne è un esempio l’onicofagia, progressivamente in evoluzione dai due ai sei anni.
Altrettanta considerazione meritano le scariche psicomotorie, definite come manifestazioni motorie primitive e ritmate, che anticipano il passaggio dal movimento all’azione, e che scompaiono cioè, quando il bambino sarà in grado di non subire più il proprio movimento, ma di darne una direzione e uno scopo più definito. Tra le varie forme di abitudini motorie autolesive, particolare importanza assume l’”head banging”, ovvero un’attività di dondolio a grande ampiezza intervallata periodicamente da un colpo più o meno violento alla testa. Varie sono state le ipotesi proposte nell’intento di spiegare il fenomeno:
dall’autostimolazione erotica, alla ricerca di soddi sfazione di bisogni sensoriali fino al tentativo di scaricare la tensione causata dal dolore associato alla comparsa degli incisivi. In ogni caso queste manifestazioni che compaiono di norma a otto mesi, si concludono in media diciassette mesi dopo, e permettono al bambino di entrare con più efficacia in rapporto con gli oggetti esterni. Contrariamente,ciò non avviene nel bambino psicotico, in cui si struttura come atto auto-mutilante e diventa una parte permanente del repertorio comportamentale. L’alterato sviluppo psichico e cognitivo, porteranno questi bambini a non abbandonare tali modalità espressive, e a non giungere mai alla maturazione di altri meccanismi formativi più adattivi e articolati.
I comportamenti etero-aggressivi
Dall’osservazione del bambino si constata che man mano che le condotte autolesive diminuiscono, tende ad aumentare la frequenza di comportamenti etero -aggressivi, che cominciano a comparire verso l’anno di età, e raggiungono due picchi, a due e a quattro anni. In particolare l’aggressività è prima agita (il bambino è collerico, attacca, morde, graffia), e poi simbolica (espressa sul piano generalmente verbale) .
A due anni, con la crisi dell’opposizione, è frequente e normale osservare atteggiamenti aggressivi. Il bambino rifiuta ciò che gli si propone, reagisce ai limiti e ai divieti con spinte, graffi, sputi, respinge le coccole: è un primo tentativo di provare la propria solidità emozionale nel disaccordo, di affermare la propria personalità differenziandosi da quella dell’altro. Il fatto che queste condotte si presentino solo con i genitori, è un importante indicatore del fatto che il bambino ha interiorizzato un rapporto soddisfacente e sa che essi non soccombono ai suoi attacchi; in un certo senso egli sa che “può permettersi” di allontanarsi da loro.
L’obiettivo dell’adulto è qui, promuovere l’espressione dell’aggressività in tutta la sua potenzialità evolutiva, trasformarla cioè da aggressività agita ad aggressività pensata. Ciò avviene fisiologicamente nello sviluppo del bambino, che, accompagnato dalla “madre sufficientemente buona”, impara a modulare sempre più le proprie strategie comunicativo-espressive, incanalando l’energia aggressiva, in modo che non sia più aggressione all’altro, ma curiosità, confronto, gioc o e interesse per il mondo esterno.
Clinica dell’aggressività
Il problema dell’aggressività, si fa particolarmente rilevante quando invece associato a determinate condizioni o patologie dello sviluppo, dove rappresenta un tratto comportamentale piuttosto preponderante che può ostacolare anche pesantemente il percorso evolutivo del bambino.
Si passeranno ora in rassegna alcuni grandi quadri patologici, rispetto ai quali sono stati identificati, a più livelli, condotte o atti aggressivi.
L’approccio al bambino, resta tuttavia sempre globale e olistico, e va ben oltre
l’etichetta diagnostica, che rappresenta unicamente un punto di partenza. Solo la comprensione reale del significato che il comportamento assume il quel momento e per quel bambino potrà essere d’aiuto per l’individuazione delle strategie d’intervento e per la stesura del progetto terapeutico.
Aggressività e sindromi genetiche
Lo studio condotto da Powis e Oliver (2014) ha individuato e confrontato con la letteratura precedente, la rispettiva prevalenza dei sintomi aggressivi nei giovani pazienti affetti da alcune sindromi genetiche quali: Cri du chat (CdCS), Smith- Magenis (SMS), X fragile (FXS), Angelman syndrome (AS), Cornelia de Lange (CdLS), Prader Willi (PWS), Williams (WS) e Down (DS). I dati raccolti evidenziano molte variabili all’interno dei singoli studi in analisi, tuttavia la CdCS è risultata la sindrome i cui comportamenti aggressivi si manifestano con maggior frequenza (18,5% - 88%), seguono poi nell’ordine la SMS (57 – 87,5%), FXS (14% - 75%), AS (10% - 73%), CdLS (7,4% - 75%), PWS (10,4%,73%), WS (6,7% - 15%) e DW (3,7% - 12%). In generale, i fattori strettamente correlati con l’aggressività, si sono dimostrati essere le ridotte capacità comunicative, l’impulsività, l’iperattività e i comportamenti ripetitivi.
Gli studi che hanno affrontato la peculiarità delle caratteristiche dell’atto aggressivo in queste sindromi, si sono però rivelati spesso metodologicamente non validi, poiché indici come il sesso, l’età o il sottotipo sindromico, non sono sempre stati considerati.
Si possono però individuare alcune linee comuni, tali per cui nella CdCS, si sono osservate condotte aggressive soprattutto fisiche ed etero-dirette, così come per la AS; nella FXS, nella CdLS e nella SMS sono emersi anche comportamenti autolesivi, spesso come modalità di attirare a sè l’attenzione dell’adulto; nella PWS, sembra inoltre che il deficit nello switch attentivo, sia la principale ca usa di crisi di rabbia e aggressione in seguito a un cambiamento della routine.
Un’altra malattia genetica i cui connotati comportamentali sono particolarmente rilevanti, è la sindrome di Lesch-Nyhan. Anderson ed Ernst (1994), dimostrarono che in questi soggetti l’aggressività, che si esplica sia in modo fisico che verbale, etero-diretto e più spesso auto-diretto, seppur generata da squilibri biochimici, è anche suscettibile a fattori stressogeni fisici ed emozionali.
Se ne ricava che le caratteristiche intrinseche del soggetto e della sindrome, sono sempre confrontabili e in parte modificabili dalle peculiarità dell’ambiente e dallo stile comunicativo e interattivo del partner relazionale. Ciò implica importanti ripercussioni sui metodi d’intervento con questi bambini: a seconda della funzione a cui il comportamento aggressivo si riferisce, più che l’”aggressione al sintomo”, sarà importante lavorare sulle problematiche sottostanti, utilizzando le strategie utili per quel bambino e modificando il contesto spazio-temporale-relazionale nel modo per lui più opportuno e appropriato.
Aggressività e deprivazione affettiva
La deprivazione affettiva nel bambino, e le conseguenze che queste riportano sui piani emotivo, cognitivo e comportamentale, sono state a lungo studiate nei bambini abbandonati, istituzionalizzati, o vittime di violenze.
Da Spitz (1946) alla Bender (1953), le ricerche hanno individuato nell’aggressività un sintomo molto comune tra questi soggetti. Se tra i 12 e i 18 mesi essa è diretta principalmente contro se stessi, si manifesta più avanti in forma diffusa, etero -diretta e priva di ansia.
Spettacolari comportamenti auto mutilanti (colpi di testa contro i muri, morsi alla lingua, alla mano, alle labbra) manifestatisi nella forma di crisi di “furore distruttivo”, sono stati osservati con alta frequenza nei bambini deprivati.
Gli studi longitudinali che seguono l’evoluzione dei bambini nei quali è stato osservato un comportamento aggressivo, sono ancora molto scarsi. La Bender tuttavia, basandosi su un campione piuttosto ristretto, ritiene l’aggressività reattiva a una carenza affettiva precoce, possa evolvere nel tempo come ritardo affettivo e intellettuale, e che il comportamento aggressivo si possa strutturare nelle forme di “baruffe e botte”.
Come già espresso dagli psicologi del sé, la presenza stabile e sicura del caregiver dai primi istanti di vita, è dunque, assolutamente indispensabile per il bambino, non solo per l’assolvimento dei cosiddetti bisogni primari, ma soprattutto, attraverso il rispecchiamento empatico, per la formazione di un Sé altrettanto sicuro, coeso, separato e differenziato dalla figura di riferimento.
Aggressività e disturbi della comunicazione, del linguaggio e dell’apprendimento
L’aggressività può manifestarsi in tutti quei casi in cui il soggetto sia vittima di un disagio interno causato da una difficoltà di relazione o comunicazione e che si può esprimere come bassa autostima, insicurezza o sfiducia. L’assenza del linguaggio soprattutto, può favorire il mantenimento di una modalità di funzionamento psichico arcaica (si veda ad esempio il caso delle paralisi cerebrali infantili con ritardo mentale e disartria associate).
Ciò si rende palese anche in bambini che presentano un distu rbo specifico dell’apprendimento (DSA), in quanto circa nel 45% dei casi riporta in comorbilità un disturbo del comportamento (Ackerman e Dykman, 1991).
Il disturbo specifico della lettura, data l’alta frequenza tra la popolazione scolastica, è stato maggiormente oggetto di studio per quanto riguarda le problematiche emozionali e comportamentali correlate.
Arnold (2005), in particolare, riferisce che bambini e adolescenti con difficoltà di lettura sono più esposti al rischio di riportare sintomi ansiosi o depressivi, ma non è raro osservare dello stesso soggetto, passaggi da atteggiamenti di ritiro a scoppi di rabbia e aggressività.
Rutter (1970) sottolinea che il legame tra questi due disturbi possa essere di tre tipi:
- La dislessia è causata dall’aggressività: il disturbo del comportamento primario, impedisce l’acquisizione delle normali abilità di lettura;
- L’aggressività è una conseguenza della dislessia: prospettiva basata sulle teorie comportamentali di frustrazione-aggressione;
- I due disturbi procedono parallelamente.
Anche in questo caso, l’accoglimento delle problematiche emozionali, il lavoro sull’autostima e sull’accettazione del disturbo, oltre che sulle specifiche problematiche d’apprendimento, saranno molto più adeguate ed efficaci a lungo termine, piuttosto che il trattamento del sintomo in sè.
Aggressività e disabilità intellettiva (ID)
E’ dimostrato, che la prevalenza di comportamenti aggressivi in soggetti con disabilità intellettiva (ID) oscilla tra il 10% (Holden e Gitlesen, 2006, Tyrer et al.
2006) e il 50% (Benson e Brooks, 2008, Crocker et al., 2006).
Si è osservato inoltre, come gli atti autolesivi quali pizzicarsi, graffiarsi, mordersi, picchiare la testa o colpirsi con i pugni, sono più frequenti negli individui con più severa disabilità intellettiva e con deficit del linguaggio espressivo (Mc Clintock et al., 2003; Oliver et al., 1987).
Interessante è lo studio di Petty et al. (2014) che si propone di indagare il fenomeno aggressivo nei soggetti con ID, rilevando nel dettaglio i principali fattori di rischio.
I dati ricavati dallo studio dimostrano che lo sviluppo di condotte aggressive è spesso
l’evoluzione di:
- precoci problematiche di salute con episodi dolorosi;
- comparsa altrettanto precoce di comportamenti stereotipati e ripetitivi;
- Iperattività e impulsività.
Le ipotesi che tentano di spiegare il fenomeno aggressivo in questi soggetti, prendono spunto principalmente dalle teorie psicodinamiche e soprattutto dall’analisi oggettiva della peculiare struttura psichica dell’individuo.
La povertà di strategie cognitive, comunicative e di controllo esecutivo, la poca consapevolezza del sè corporeo e del sé come individuo mentalmente e psichicamente separato dall’altro e le difficoltà di gestione e controllo delle proprie emozioni, rendono il bambino con ID un soggetto particolarmente esposto al rischio di manifestare condotte di tipo aggressivo, che possono assumere il valore di:
- Scarsa tolleranza alla frustrazione, e quindi incapacità di trovare una soluzione alternativa a quella negata;
- Modalità espressiva di un disagio, non altrimenti comunicabile;
- Confusione e disorganizzazione sensoriale e percettiva, che li porta a non essere sempre in grado di distinguere il sé dall’altro e di esprimere una sensazione piacevole o spiacevole in modi e contesti adeguati;
- Instabilità e povertà emotiva.
Le manifestazioni aggressive nei bambini con ID, sono dunque il riflesso di una profonda frammentarietà cognitiva, emotiva, percettiva e relazionale, che necessita, almeno in parte di trovare una stabilità, un significato.
Il neuropsicomotricista, attraverso la ricomposizione della frammentarietà delle azioni del bambino, la loro amplificazione e micro-variazione, può facilitare il processo di tolleranza e adeguamento all’interno della relazione, ed essere un ponte verso la comprensione della realtà e la socializzazione.
Aggressività e disturbo dello spettro autistico (ASD)
Nei soggetti con ASD, l’aggressività è un sintomo piuttosto comune. E’ stimato infatti che più del 50% dei bambini e adolescenti con ASD manifestano aggressività fisica nei confronti del caregiver, e circa il 70% di essi ha mostrato tali comportamenti in passato (Kanne, Mazurek 2011, 2013).
Fattori di rischio per la comparsa di condotte aggressive tra i soggetti con ASD si sono dimostrati essere: povertà di strategie comunicative, basso QI, sesso maschile, giovane età e peggiori condizioni socio economiche della famiglia (Lahey et al. 1999).
Il quoziente intellettivo, tuttavia, non si è rivelato essere un fattore sempre indicativo, poiché comportamenti aggressivi sono stati osservati anche in soggetti ASD ad alto funzionamento. Nel dettaglio, lo studio condotto da Quek et al. (2012) riscontrò che il 17% di soggetti giovani adulti con Sindrome di Asperger, riportava comunque livelli di rabbia clinicamente significativi.
L’aggressività, sebbene sia uno dei principali sintomi associati all’autismo, non è certamente il solo; disturbi del sonno, problemi gastro-intestinali, e difficoltà nell’integrazione sensoriale, si possono ritrovata con una certa frequenza e possono essere correlati all’aggressività (Tseng Fu et al, 2011).
Frequente, è anche la presenza di comportamenti autolesivi, che, come per la disabilità intellettiva, sono spesso temporalmente anticipati dalla presenza di movimenti stereotipati e ripetitivi (Symons et al. 2005).
Anche nel caso del Disturbo dello spettro autistico il fenomeno aggressivo può assumere di volta in volta, un significato diverso; nello specifico, possono manifestarsi in forma impulsiva, oppure non impulsiva. Nel primo caso, sono spesso automutilazioni, in cui il bambino si lascia cadere per terra, si dà impulsivamente dei colpi alla testa, si morde etc.., e si osservano specialmente durante gravi crisi di agitazione secondarie ad una frustrazione.
Nel secondo caso invece, l’automutilazione o l’azione etero-diretta può ugualmente seguire a una frustrazione, oppure compensare una difficoltà comunicativa, un disordine emotivo o di integrazione sensoriale, un’alterata soglia di aurosal, o un’assenza di percezione del dolore, che contribuiscono tra l’altro alla disorganizzazione dello schema corporeo.
La comprensione del problema, l’anticipazione dei bisogni, e la scelta ponderata di quando e come introdurre cambiamenti, possono aiutare a prevenire determinate condotte aggressive nel bambino con ASD, e condurlo all’autonoma ricerca di altre e più adattive modalità espressivo-comunicative.
Aggressività e disturbi del comportamento
Rientrano in questa categoria, il disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività (ADHD), il disturbo oppositivo-provocatorio e il disturbo della condotta.
Per l’ADHD, in particolare, si è visto come i correlati neurofisiologici siano da ricercare soprattutto in una disfunzione della regione prefrontale, deputata al controllo esecutivo. Il risultato è un bambino problematico sul piano dell’autoregolazione cognitiva, emotiva e di conseguenza comportamentale.
Non è ancora chiara la precisa eziologia del sintomo aggressivo, ma sembra che i principali fattori di rischio siano da ricercare sia in ambito psicobiologico che ambientale. Le difficoltà a mantenere un’attenzione sostenuta, a cogliere i dettagli che interessano e tralasciare gli altri, sfociano sicuramente in un eccessivo livello di attività motoria, in agitazione costante, in incapacità di attendere ed elaborare le informazioni emotive e cognitive e di programmare o inibire risposte comportamentali. L’atto aggressivo non sarà quindi un’azione volontaria e pianificata allo scopo di recar danno, ma molto più di frequente, è l’esito di una mancata possibilità di controllare il “flusso di pensieri e di azioni” .
L’ipotesi biologica però non è sufficiente a spiegare un disturbo tanto vario e frequente, ed è quindi necessario considerare anche gli elementi ambientali, che sembra abbiamo un peso addirittura maggiore nell’espressione di condotte aggressive (King, Waschbusch, 2010). Ercan e colleghi (2014), dimostrarono a tal proposito che, accanto a fattori neurobiologici, lo stile genitoriale (soprattutto materno) e la familiarità positiva per disturbi psichiatrici siano importanti indici di rischio per manifestare comportamenti aggressivi di vario tipo.
Il peso che l’ambiente ha nel determinare l’evoluzione e l’espressione del bambino comportamentale, suggerisce che esso sarà altrettanto fondamentale al momento del trattamento. La coerenza, la definizione di regole specifiche, e la possibilità di esperire le conseguenze dei propri comportamenti, rappresentano poche ma efficaci indicazioni per le quali si chiede la collaborazione di tutti coloro che sono coinvolti nella cura del bambino, ai fini di creare un accordo su quali siano i comportamenti da modificare, e di dare continuità e alle strategie utilizzate in tutti i contesti di vita.
Il trattamento farmacologico dell’aggressività
Si è visto come i comportamenti auto o eterolesivi, quando associati a quadri clinici particolarmente gravi come il ritardo mentale grave, il disturbo autistico, o alcune sindromi genetiche, possono costituire un ulteriore gravoso ostacolo al processo maturativo del bambino condizionando lo stesso in senso peggiorativo, e rendendone particolarmente difficoltosa la gestione da parte del caregiver. L’intervento terapeutico ed educativo globale, che coinvolge attivamente famiglia e contesti educativi, non sempre è sufficiente a far fronte a comportamenti problema che possono seriamente mettere a rischio l’integrità fisica del bambino e delle persone attorno a lui; ecco che talvolta un intervento multimodale che preveda anche un trattamento farmacologico mirato e diretto al sintomo può essere molto più efficace.
In generale gli obiettivi di un trattamento farmacologico15 in età evolutiva devono essere:
- Il miglioramento della qualità di vita del bambino e della famiglia;
- La facilitazione dell’accesso ai trattamenti non medici;
- Il potenziamento degli effetti dei trattamenti non medici;
- La prevenzione dei comportamenti auto-etero lesivi;
- Il trattamento di manifestazioni collaterali e associate in comorbilità.
Se ne deduce che l’obiettivo ultimo dell’uso del farmaco non è limitato alla riduzione del sintomo fine se stesso, quanto a portare il bambino ad uno stato di maggior benessere, tranquillità, e predisposizione alla relazione e all’apprendimento, in modo tale che possa fruire al meglio degli altri interventi educativo-riabilitativi.
Ne consegue che l’assunzione del medicinale deve preservare e non compromettere il funzionamento dell’individuo, obiettivo raggiungibile solo attraverso l’attento monitoraggio degli effetti indesiderati, nonché con periodi di verifiche di efficacia e necessità.
Numerosi studi hanno analizzato l’efficacia del trattamento farmacologico sintomatico dei pazienti in età evolutiva, molti dei quali riguardano campioni di soggetti con ritardo mentale grave o con disturbo dello spettro autistico.
L’ampia variabilità clinica che caratterizza queste persone, risulta essere però un importante elemento di rilievo, e non permette di dare per mai per scontata l’efficacia di un farmaco, anche quando questo si è rilevato ampiamente migliorativo per la maggior parte degli altri soggetti.
Un’ampia varietà di studi pubblicati a partire dagli anni sessanta, dimostrava una modesta riduzione dei sintomi comportamentali in pazienti autistici, in seguito al trattamento con neurolettici tradizionali, farmaci che vanno ad agire selettivamente su varie classi di recettori del sistema nervoso centrale quali dopaminergici, serotoninergici, alfadrenergici, istaminergici, colinergici, nonché sui canali del calcio.
La sempre più frequente incidenza di effetti collaterali quali discinesia tardiva ed altri sintomi extrapiramidali, ha però promosso lo studio dei cosidetti Neurolettici Atipici, classe che comprende il risperidone, la clozapina e l’olanzapina, dimostrandone una certa efficacia su alcuni sintomi quali aggressività, autolesionismo, eccessi di rabbia e stereotipie.
Se la clozapina è comunque associata ad alcuni effetti collaterali tra cui leucopenia e aumento di crisi epilettiche, il risperidone, antagonista della dopamina e della serotonina, è preferito in età evolutiva proprio perché accanto ad una buona efficacia terapeutica, si riscontra anche una minor incidenza di effetti secondari tra cui sedazione, manifestazioni distoniche o discinesia tardiva.
Secondo la teoria biologica che attribuisce la causa del comportamento auto o eterolesivo allo spropositato aumento di oppioidi endogeni, è stato fatto grande uso, in passato, del naltrexone, antagonista degli oppiacei.
Gli studi che si sono concentrati su questo farmaco, sebbene metodologicamente validi, sono tuttavia pochi e riportano risultati tra loro contrastanti. Se ne evince che l’efficacia di questi preparati possa essere valido solo per una stretta cerchia di individui, probabilmente per coloro che hanno una ridotta sensibilità al dolore.
L’ipotesi che il comportamento aggressivo derivasse da bassi livelli ematici di serotonina, ha recentemente aperto le porte a una nuova classe di farmaci: gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI).
Anche in questo caso gli studi sono ancora molto scarsi, si è tuttavia osservato che la positività della risposta, spesso correlata con una familiarità per il disturbo dell’umore, porta ad una riduzione del comportamento aggressivo e ad una maggior disponibilità alla modificazione ambientale o della routine quotidiana. (C houinard et al 1990)
La somministrazione dei farmaci, specialmente in età evolutiva, resta comunque solo un aspetto del trattamento, incluso all’interno di un programma terapeutico multimodale e globale supportato dall’alleanza con la famiglia.
La scelta dell’uso del farmaco non deve mai essere, quindi, la risposta immediata a un sintomo né tanto meno a una richiesta; esso va introdotto solo quando tale sintomo diventa realmente fonte di sofferenza per il bambino, o ostacolo all’avvio di altri approcci terapeutici, e inserito in una consapevolezza complessiva dei disturbi del bambino.
-
1 Storr A. (1920-2001) fu psichiatra e saggista inglese. Tra il 1960 e il 1996 ha pubblicato numerosi saggi tra cui “L’aggressività nell’uomo” (1968) De Donato ed., Bari.
-
2 D.W. Winnicott (1975) Dalla pediatria alla Psicanalisi capitolo XVI “L’aggressività ed il rapporto con lo sviluppo emozionale” Martinelli, Firenze.
-
3 J. De Ajuriaguerra (1979) Manuale di psichiatria del bambino, capitolo XIII “Psicopatologia delle pulsioni aggressive” pag. 465-506, Masson, Milano.
-
4 Freud S. (1920) Al di là del principio di piacere. L’autore descrive il gioco del piccolo Ernst di diciotto mesi che, tenendo in mano un rocchetto legato ad una cordicella, si diverte a lanciarlo più volte al di là del suo lettino, facendolo scomparire; poi, tirando nuovamente fuori il rocchetto, egli emette, esclamazioni di gioia. Attraverso questo gioco, egli ha la possibilità di provocare in prima persona la scomparsa e la ricomparsa della madre assente, diventando capace, sia di sublimare i traumi sofferti passivamente, sia di conservare il legame oggettuale con la madre. Tale gioco simbolico può liberare il bambino dall’ansia e dall’angoscia che si producono dall’allontanamento e dalla scomparsa della madre riproducendone appunto la ricomparsa e negandone la definitiva separazione.
-
5 Lebovici S. (1915-2000) fu psichiatra e psicanalista francese. Citato in De Ajuriaguerra (1979), Manuale di psichiatria del bambino pag.475.
-
6 Le intuizioni che P.Fonagy presenta in “Aggression and the psychological Self”, International Journal of Psychoanalysis (1993), sono state anticipate da alcuni autori del passato tra cui: Bion (1962), coi concetti di reverie e di madre “contenitore” emotivo; Winnicott (1971) con il concetto di “identificazioni incrociate” tra madre e bambino; Loewald (1978) secondo il quale la riflessione su di sé si basa sul rispecchiamento reciproco all’interno della diade.
-
7 Secondo gli autori di Frustration and aggression la condotta aggressiva ha lo scopo di infliggere un danno agli altri; essa prosegue fino a quando il danno è stato prodotto, e termina quando lo scopo è stato raggiunto. Di conseguenza le cosiddette “aggressioni strumentali” il cui scopo ultimo non è ledere la vittima, possono essere considerate aggressioni solo quando lo scopo perseguito non giustifica l’esecuzione dell’atto dannoso.
-
8 L’esperimento di Kuhn, Madsen e Becker (1967) prevede che alcuni bambini vengano sottoposti a una frustrazione che consiste nel rifiuto di un dolce che era stato promesso; il gruppo di controllo invece lo riceve. Successivamente una metà di ognuno dei due gruppi assiste alla proiezione di un film in cui un adulto colpisce un pupazzo raffigurante un uomo; le altre due metà guardano un filmato emotivamente neutro. I risultati ottenuti dimostrano che i bambini che avevano seguito il primo filmato, a differenza degli altri, tendevano a riproporre la stessa modalità aggressiva nel gioco, ma non si sono mostrate differenze tra i bambini che avevano subito la frustrazione e quelli del gruppo di controllo.
-
9 Lo studio, pubblicato in Child abused & Neglect (2015), è stato condotto su campioni di 10,496 uomini e 12,877 donne vittime di abusi fisici, sessuali o esposti a violenza domestica durante l’infanzia. Gli abusi fisici e sessuali si è visto essere per entrambi i generi fattori di rischio per la comparsa dei sintomi che soddisfano i criteri diagnostici dell’ADHD, mentre l’esposizione alla violenza domestica è dimostrato essere fattore di rischio significativo solo nelle donne.
-
10 Bonino S. e Scaglione G. (1978) Aggressività e adattamento, Boringhieri, Torino. Gli autori sostengono che “la ragione basilare per cui il comportamento dell'uomo è scarsamente ritualizzato è a nostro parere da ricercarsi nella plasticità tipica dell'uomo. Rispetto agli animali l'uomo non viene alla luce con un corredo di reazioni rigide e stereotipate, programmate e poco variabili. L'uomo è invece, come più volte abbiamo già notato, scarsamente dotato sul piano istintuale; anche i comportamenti filogeneticamente determinati sono nell'uomo più plastici e maggiormente legati alle influenze ambientali e dell'ontogenesi. Questa plasticità è alla base del prodigioso sviluppo e della stupefacente complessità del comportamento umano, capace di far fronte alle situazioni più nuove e insospettate. [...] La rigida determinazione del comportamento è inversamente proporzionale all'evoluzione filogenetica. Una reazione rigidamente stereotipata e preordinata è alla base di un equilibrio labile, che non è in grado di tener conto delle variazioni di una situazione e di adattarvisi plasticamente”
-
11 Lo studio condotto presso l’università dell’Illinois prevedeva che ognuno dei 59 ratti ut ilizzati per l’esperimento, fossero collocati in gabbie individuali con cibo costantemente a disposizione e acqua limitata tale per cui se il ratto beveva oltre il tempo consentito viene liberata una scossa la cui intensità aumenta con l’ammontare degli errori. Gli autori notano che i ratti con lesioni all’amigdala centrale e basolaterale ricevevano più scosse degli altri, e che il campione con lesione all’amigdala mediale mostrava più comportamenti aggressivi di difesa nei confronti degli altri ratti posti poi nella stessa gabbia.
-
12 Tajima-Pozo K., Ruiz-Manrique G., Yus M., Arrazola J., Montañes-Rada F. (2015) Correlation between amygdala volume and impulsivity in adults with attention-deficit hyperactivity disorder. Acta Neuropsychiatrica n. 28 pag. 1-6.
-
13 Lo studio in questione, condotto da Soloff P.H., Meltzer C.C., Becker C., Greer P.J. Kelly T.M. e Constantine D., e pubblicato nella rivista “Psychiatry Research” (Impulsivity and prefrontal hypometabolism in borderline personalità disorder, n. 30 pp. 153-163), prevedeva la somministrazione di test neuropsicologici a un gruppo di pazienti donne con disturbo della personalità Borderline, la misurazione dei comportamenti auto ed etero-aggressivi e in seguito la quantificazione del livello di metabolismo del glucosio nella corteccia prefrontale tramite la tecnica della PET. I test hanno mostrato deficit nelle funzioni di problem solving, pianificazione, attenzione selettiva e controllo inibitorio del comportamento, la PET ha evidenziato un metabolismo prefrontale molto più basso, e una frequenza molto più alta di comportamenti aggressivi. Questi due ultimi dati sono inoltre inversamente proporzionali, ovvero all’aumentare dell’uno, l’altro decresce.
-
14 Anna Jean Ayres (1920-1988) fu psicologa clinica, terapista occupazionale e fondatrice della clinica americana “Ayres” a Torrance, California. Il lavoro con i bambini con paralisi cerebrali e difficoltà di apprendimento, ha portato la Ayres a sviluppare una propria teoria circa i processi di integrazione sensoriale e a coniare per prima l’espressione “disfunzione dell’integrazione sensoriale”. Concependo il comportamento umano come “espressione del cervello”, ella era convinta che il lavoro sulla processazione sensoriale e sulle sue disfunzioni fosse di primaria importanza per risolvere alla radice alcuni problemi di tipo emotivo o comportamentale.
-
15 Linee guida per l’autismo (2005) Società italiana di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (SINPIA)
Indice |
| SOMMARIO |
|
| CONCLUSIONI |
| BIBLIOGRAFIA |
| APPENDICE |
| Tesi di Laurea di: Giulia BIDINOST |